di Emiliano Brancaccio[1]
Introduzione
“Chi vuole più lavoro dica no. Togliamo il freno al lavoro. Non rimanere indietro. No alla disoccupazione”.
Riportati su grandi manifesti a sfondo rosso e diffusi in tutta Italia, questi slogan sono stati coniati dalle organizzazioni imprenditoriali al fine di contrastare il referendum del 15 giugno per l’estensione dell’articolo 18. Gli slogan evocano una visione del sistema economico che negli ultimi anni ha goduto di un notevole successo, e che attualmente appare piuttosto radicata nell’opinione dei cittadini. Si tratta della visione secondo cui l’elevata flessibilità del mercato del lavoro costituirebbe un imprescindibile fattore di stimolo per la crescita, l’occupazione e la competitività di un paese. Nel corso degli ultimi anni questa idea ha rappresentato il sostegno logico fondamentale a tutte le proposte di rimozione dei vincoli che attualmente regolano il mercato del lavoro, dai minimi salariali fissati per legge o per contratto alle norme che limitano la libertà di licenziamento.
Gli economisti di orientamento liberista hanno sempre offerto rigorose argomentazioni in difesa della flessibilità del mercato del lavoro. Arthur Cecil Pigou, ad esempio, riteneva che la disoccupazione di massa degli anni ’30 dipendesse soprattutto da salari troppo elevati rispetto alla produttività del lavoro, e che solo accettando una riduzione degli stessi si sarebbe raggiunta la piena occupazione.[2] Pigou giunse addirittura a nobilitare la figura del crumiro, sostenendo che il suo comportamento, fiaccando i sindacati e rendendo i salari flessibili verso il basso, avrebbe prima o poi favorito il raggiungimento dell’equilibrio di pieno impiego. Più di recente il premio Nobel James Heckman, tra gli altri, ha sostenuto che la cosiddetta eurosclerosi, ovvero la difficoltà per l’Europa di raggiungere gli elevati tassi di crescita e i bassi tassi di disoccupazione americani, dipende in modo significativo dalle forti rigidità presenti nei mercati del lavoro del vecchio continente rispetto al mercato statunitense.[3]
Questi argomenti risultano ben noti al grande pubblico, dal momento che la maggioranza dei politici e dei commentatori usa riproporli a mo’ di litania in tutte le occasioni di confronto e di discussione. Ciò di cui il grande pubblico non è a conoscenza, invece, è che la visione che considera la flessibilità del mercato del lavoro uno stimolo irrinunciabile ai fini della crescita, della competitività e dell’occupazione, risulta in ambito scientifico sostanzialmente minoritaria. Tra i numerosi oppositori di questa visione basterà citare i premi Nobel Robert Solow e Joseph Stiglitz, i quali hanno più volte dichiarato che i problemi del basso saggio di sviluppo, dell’elevata disoccupazione e della scarsa capacità di innovazione tecnica di un paese andrebbero risolti sul terreno delle politiche macroeconomiche, della lotta ai monopoli e alle rendite, della spesa pubblica per la ricerca e della creazione di infrastrutture, molto più che attraverso la flessibilità dei salari o lo smantellamento dei regimi di protezione dei lavoratori.[4] Una posizione, questa, che è stata condivisa e ulteriormente rafforzata, tra gli altri, dalle centinaia di economisti sottoscrittori del manifesto per una politica economica alternativa in Europa.[5]
La scarsa conoscenza dei contributi di questi studiosi, e soprattutto la diffusa riluttanza a tradurre politicamente le loro idee, hanno finora dato luogo a un triste paradosso: la visione liberista, fautrice della flessibilità del mercato del lavoro, benché scientificamente minoritaria riesce tuttora in ambito politico a riscuotere i consensi più ampi. Questo paradosso ha fortemente condizionato l’intero dibattito di politica economica europea. E in Italia, in particolare, esso ha finora pregiudicato l’avvio di una seria, credibile discussione attorno alle iniziative sindacali e politiche dell’ultimo anno e mezzo volte al mantenimento e all’estensione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. A botta di slogan, infatti, gli avversari dell’articolo 18 stanno cercando di convincere i cittadini dell’esistenza di un legame stringente tra la maggiore flessibilità sul mercato del lavoro e il maggior benessere economico. I sostenitori del referendum, dal canto loro, sono finora apparsi in difficoltà di fronte a quegli slogan, e hanno pertanto deciso di identificare la loro azione politica nella sola questione di principio, nella “battaglia di civiltà” contro i licenziamenti ingiustificati.
Ebbene, proprio al fine di vincere la battaglia di civiltà per la tutela contro i licenziamenti ingiustificati, è giunto il momento di confrontarsi con i fautori della flessibilità proprio sul terreno della politica economica. E’ possibile infatti dimostrare che il referendum per l’estensione dell’articolo 18 non costituisce semplicemente una iniziativa ineccepibile sul piano etico, ma rappresenta soprattutto un’occasione per mettere a conoscenza i cittadini dell’esistenza di un razionale, credibile progetto di politica economica immediatamente applicabile all’Europa e all’Italia, un progetto alternativo agli indirizzi di matrice liberista tuttora dominanti.
Nel presente studio esamineremo le principali critiche ai regimi di protezione dei lavoratori (e in particolare all’art.18) avanzate dai fautori della flessibilità, al fine di evidenziare la sostanziale inconsistenza delle loro argomentazioni. In uno studio successivo proveremo invece a delineare lo scenario di politica economica alternativa all’interno del quale l’iniziativa referendaria troverebbe piena legittimazione, non solo sul piano etico ma anche su quello più strettamente economico.
Una critica agli argomenti degli avversari dell’articolo 18
1. L’articolo 18 pregiudica la crescita dimensionale delle imprese[6]
L’argomentazione è falsa, ed è davvero sorprendente che il governo Berlusconi l’abbia adoperata a sostegno di una possibile deroga all’articolo 18. Se questo articolo pregiudicasse la crescita delle imprese, infatti, si dovrebbe registrare un addensamento delle stesse al di sotto della soglia dei 15 dipendenti, a partire dalla quale l’articolo viene attualmente applicato. Ma le indagini empiriche smentiscono categoricamente l’esistenza di un simile addensamento.
Le piccole imprese infatti si concentrano soprattutto attorno a una media di 3,6 dipendenti, ben lontana dal limite dei 15 previsto per l’applicazione dell’articolo 18.[7] A ciò si aggiunga che in Italia il 95% delle imprese ha meno di 10 addetti ed assorbe ben il 47% dell’occupazione totale, contro il 21% della Germania, il 22 della Francia e il 27% del Regno Unito.[8]
Inoltre, tra il 1991 e il 1996, mentre tra le imprese incluse nella classe 10-15 dipendenti si è registrato un calo dell’occupazione del 2,7%, tra le imprese appartenenti alle classi 16-19 e 20-49 è stata rilevata una crescita occupazionale rispettivamente dell’1% e dell’1,7%. Il tutto nonostante che l’articolo 18 si applichi solo a queste ultime due classi di addetti, mentre la prima ne risulta esentata.[9]
E’ stato poi rilevato che l’eventuale rimozione dell’articolo 18 avrebbe effetti assolutamente insignificanti sulla propensione a crescere delle imprese. L’eliminazione dell’art.18 infatti aumenterebbe la probabilità che un’impresa superi la soglia dei 15 dipendenti di appena l’1,5%.[10] Oppure, detto in altri termini, essa produrrebbe un aumento medio della dimensione delle imprese inferiore all’1%, un risultato davvero modesto se si considera che le imprese italiane soffrono di un deficit dimensionale rispetto alle imprese del resto d’Europa che si aggira intorno al 50%.
Questi dati hanno indotto l’Istat a dichiarare espressamente che “non sembra apprezzabile l’effetto soglia per la crescita dimensionale intorno ai 15 dipendenti”.[11] Una conclusione categorica, questa, che è stata tra l’altro confermata persino da un gruppo di studiosi del Centro studi Confindustria, i quali nel 1999 affermavano: “Quanto alle soglie, l’analisi empirica non sembra rivelare salti di rilievo nella numerosità delle imprese in corrispondenza dei valori più critici (15 e 35 dipendenti), al contrario di quanto dovrebbe accadere nell’ipotesi in cui la soglia fosse avvertita come un limite da non valicare”.[12] Considerata l’ostinazione con la quale il presidente D’Amato continua a considerare l’articolo 18 un drammatico vincolo alla crescita delle imprese, si deve ritenere che i vertici di Confindustria non coltivino molto l’abitudine di leggere gli studi da essi stessi commissionati.
2. I regimi di protezione dei lavoratori, e in particolare l’articolo 18, disincentivano le assunzioni e creano disoccupazione
Siamo ancora una volta di fronte ad un’argomentazione insostenibile. La verità è che, nonostante gli sforzi compiuti da numerosi economisti di orientamento liberista, nessuno è finora riuscito a dimostrare che la libertà di licenziamento implichi un abbattimento della disoccupazione. Un tentativo, in questo senso, era stato compiuto dall’OCSE, in uno studio del 1999 dedicato alle rigidità del mercato del lavoro.[13] Ma contrariamente alle attese di molti apologeti della flessibilità, quello studio rivelò la sostanziale assenza di legami tra i vincoli ai licenziamenti e il tasso di disoccupazione.
Si osservi a tal proposito la figura 1, estratta proprio dalla suddetta indagine dell’OCSE e riferita agli anni ‘90. Sull’asse orizzontale è riportato l’indice di protezione dei lavoratori (EPL) nei vari paesi esaminati, vale a dire una misura complessiva dell’entità dei vincoli ai licenziamenti, alle assunzioni a tempo determinato e ad altre possibili iniziative degli imprenditori. Più alto è l’indice maggiori sono i vincoli per le imprese e le tutele per i lavoratori. Sull’asse verticale è invece riportato il tasso di disoccupazione. Ebbene, il grafico chiarisce che non vi è la benché minima possibilità di affermare che vincoli più stringenti comportino una più elevata disoccupazione. Basti notare in proposito come l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e l’Irlanda, paesi caratterizzati da bassissimi livelli di protezione dei lavoratori, abbiano fatto registrare negli anni ’90 dei tassi di disoccupazione elevatissimi, superiori all’8% e con punte del 13-14%. Al contrario, paesi come la Germania, la Svezia, la Norvegia o il Portogallo, caratterizzati da regimi di protezione dell’impiego molto più favorevoli ai lavoratori, hanno generato dei risultati decisamente migliori sul piano della disoccupazione, con tassi ben al di sotto dell’8% !
|
Fig. 1 – Assenza di correlazioni tra l’indice di protezione dei lavoratori e il tasso di disoccupazione |
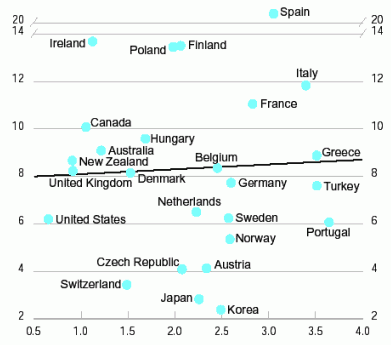 |
|
Ascisse (X): Indice di protezione dei lavoratori (EPL) |
Un simile risultato non dovrebbe del resto sorprendere. E’ chiaro infatti che l’unico effetto certo e immediato dei licenziamenti facili è la crescita dei disoccupati, mentre il possibile stimolo degli stessi alle assunzioni è molto più dubbio e controverso, dipendendo soprattutto dalle condizioni del mercato e in particolare dal livello della domanda di merci.[14]
Per quanto riguarda l’Italia, bisogna dire che il grafico evidenzia l’elevata disoccupazione che ha caratterizzato il nostro paese nell’ultimo decennio, ma esclude al tempo stesso in modo categorico che essa sia potuta dipendere dalle tutele contro i licenziamenti. Un risultato, questo, che agli occhi di molti meticolosi analisti del mercato del lavoro potrà apparire sconcertante, ma che da un punto di vista macroeconomico dovrebbe risultare pressoché ovvio. La macroeconomia infatti ci insegna che i tassi di disoccupazione dipendono da un’infinità di fattori, tra i quali le norme che regolano il mercato del lavoro non rivestono affatto un ruolo predominante. L’analisi macroeconomica ci ricorderebbe, piuttosto, che negli anni ’90 sulla nostra penisola il “ciclone Maastricht” si è scatenato con una violenza molto maggiore che altrove, generando fortissimi effetti depressivi sulla domanda, sulla produzione e quindi sull’occupazione.
Alcuni sostenitori della flessibilità del mercato del lavoro hanno tentato di rimediare all’assenza di correlazioni tra l’indice di protezione dei lavoratori e il tasso di disoccupazione proponendo un diverso tipo di misurazione. Essi, in particolare, hanno suggerito di sostituire il tasso di disoccupazione (cioè il rapporto tra i disoccupati e la forza lavoro, data dalla somma degli occupati e dei disoccupati) con il tasso di occupazione (ossia il rapporto tra occupati e popolazione in età di lavoro).[15] E’ difficile esimersi dal considerare tendenziosi simili salti da un indice all’altro alla strenua ricerca di quello in grado di confermare le correlazioni desiderate. Ad ogni modo, è in effetti vero che in presenza di un alto indice di protezione dei lavoratori si registra solitamente un basso tasso di occupazione. Tuttavia, è stato più volte chiarito che questa correlazione potrebbe non implicare alcuna relazione causale tra bassa protezione ed elevata occupazione. Si è detto ad esempio che la correlazione potrebbe banalmente derivare dal fatto che i più forti livelli di protezione dei lavoratori si registrano nei paesi mediterranei, nei quali il rapporto tra occupati e popolazione risulta basso soprattutto a causa della scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro.[16] Inoltre, è interessante notare come il tasso di occupazione non sia assolutamente in grado di incorporare il dramma fondamentale della disoccupazione. In linea di principio, infatti, per come sono costruiti gli indici si potrebbero registrare elevatissimi tassi di occupazione in corrispondenza di tassi di disoccupazione altrettanto elevati. Ma soprattutto, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, è opportuno ricordare che nell’ormai ben noto studio dell’OCSE del 1999 si afferma effettivamente che la libertà di licenziamento produce aumenti del tasso di occupazione delle donne e dei giovani, ma si aggiunge pure che li produce a scapito degli uomini adulti ! La libertà di licenziamento, insomma, tende a produrre un banale effetto di sostituzione dei maschi adulti con donne e giovani, con un evidente risparmio per le imprese sul costo del lavoro.
3. L’Italia è un paese ad elevata rigidità del mercato del lavoro
Gli avversari del referendum per l’estensione dell’art.18 potrebbero tuttavia prendere spunto dal grafico dell’OCSE per farci notare che l’Italia presenta comunque un indice di protezione dei lavoratori molto alto rispetto agli altri paesi. Essi potrebbero quindi affermare che non si può pretendere di accrescere ulteriormente quell’indice attraverso l’estensione dell’articolo 18, ma occorrerebbe piuttosto ridurlo al fine di uniformarlo alla media europea. Di fronte a un simile suggerimento si potrebbe semplicemente obiettare che, nella totale assenza di motivazioni, non si vede perché non si possa auspicare una tendenza della media europea verso indici di protezione più elevati anziché imporre all’Italia una convergenza al ribasso. Ma l’intera discussione risulterebbe immediatamente superata se si desse anche solo un’occhiata all’ultima relazione annuale della Banca d’Italia.[17] Gli economisti di via Nazionale hanno infatti notato una vistosa incongruenza nell’indicatore di protezione dei lavoratori che l’OCSE ha assegnato all’Italia. In quell’indicatore, infatti, è incluso il TFR come costo del licenziamento, laddove anche i non addetti sanno che in realtà le somme dovute ai lavoratori per il trattamento di fine rapporto rappresentano un salario differito che va pagato sempre, sia che il lavoratore venga licenziato sia che si dimetta o che vada in pensione. Inoltre, tutto si può dire eccetto che il TFR rappresenti una penale per le imprese, dal momento che queste lo considerano un vantaggiosissimo finanziamento agevolato. Seguendo dunque la critica rivolta all’OCSE dagli economisti di Bankitalia si giungerebbe a modificare radicalmente la posizione dell’Italia sul grafico. Infatti, rimuovendo il TFR dall’indicatore, il nostro paese scenderebbe nella classifica della rigidità dal 5° al 18° posto assoluto!
4. L’articolo 18 genera costi che soprattutto le piccole imprese non sarebbero in grado di sostenere
Questa idea appare smentita dal fatto, più volte rilevato dalle indagini statistiche, che i paesi caratterizzati da maggiori protezioni per i lavoratori sono anche quelli in cui si pagano i salari più bassi.[18] Insomma, l’analisi economica suggerisce l’idea che siano gli stessi lavoratori ad assumersi i costi delle protezioni, accettando remunerazioni più basse rispetto a quelle prevalenti nei paesi caratterizzati da una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro! Questa evidenza può essere rilevata in molti modi. Uno di questi consiste nel rapportare l’indice di protezione dei lavoratori (EPL) alla quota dei salari sul PIL. Ebbene, anche depurando la correlazione dalle eventuali distorsioni generate dalla diversa presenza di lavoratori autonomi nei paesi considerati, si rileva che indici di protezione più alti corrispondono a una quota salari più bassa:
|
Fig. 2 – A un’alta protezione dei lavoratori corrisponde una bassa quota salari |
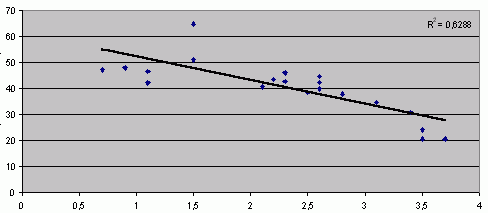 |
|
Ascisse (X): Indice di protezione dei lavoratori (EPL) |
A questa evidenza vale poi la pena di aggiungere che il modo in cui solitamente si affronta il problema degli elevati costi di una sentenza sfavorevole all’imprenditore è del tutto fuorviante. Consideriamo ad esempio la seguente ipotesi. Assumiamo che a distanza di circa 24 mesi dalla data del licenziamento[19] una sentenza dichiari quest’ultimo ingiustificato. Assumiamo inoltre che la retribuzione mensile lorda del lavoratore, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive, ammontasse alla data del licenziamento a 1500 euro. Assumiamo inoltre che in seguito alla sentenza, come accade nella maggioranza dei casi, il lavoratore opti per l’indennità di 15 mensilità piuttosto che per la reintegrazione sul posto di lavoro. Aggiungiamo infine spese legali per un totale di 5000 euro. Alla fine l’imprenditore si ritroverà a pagare una somma complessiva di 63500 euro.
Somme del genere risultano indubbiamente elevate, e sono state spesso richiamate per dimostrare che una piccola impresa non sarebbe in grado di sostenerle.[20] Ma questo modo di ragionare è altamente discutibile. Per poter affrontare correttamente la questione è necessario infatti ragionare ex-ante, ossia occorre mettersi nei panni dell’imprenditore che sta per decidere se assumere un lavoratore oppure no. L’imprenditore, in altri termini, non può considerare il costo di una eventuale sentenza a lui sfavorevole come se fosse un dato a sé stante, ma deve rapportare quel costo alla probabilità che il lavoratore che egli sta per assumere venga licenziato, lo citi in giudizio e arrivi a vincere la causa. Un semplice calcolo ci permetterà di chiarire che, anche nell’ipotesi peggiore, il costo atteso della sentenza è bassissimo, per non dire trascurabile. Noi sappiamo in proposito che nel 1998 le sentenze per licenziamento ingiustificato sono state 2216, e che nel 56% dei casi esse sono risultate sfavorevoli all’imprenditore.[21] Se ora moltiplichiamo il numero delle sentenze sfavorevoli (2216 x 0,56 = 1241) per il numero medio di anni di permanenza del lavoratore in azienda (circa 3 anni),[22] e dividiamo il tutto per il totale dei posti di lavoro creati in un anno (1.100.000),[23] otteniamo una stima tanto grossolana quanto significativa della probabilità che l’imprenditore incorra effettivamente in una sentenza che dichiari ingiustificato il licenziamento del lavoratore che egli sta per assumere: appena lo 0,3%, che diventa lo 0,02% se si divide per il totale degli occupati alle dipendenze anziché per il flusso di posti creati. Pertanto, moltiplicando il costo medio di una sentenza sfavorevole (63.500 euro) alla più alta probabilità che questa si verifichi (0,3%), si ottiene che il costo medio atteso di un eventuale licenziamento ingiustificato ammonta a 190,5 euro per tre anni, ossia ad appena 63,5 euro all’anno per ogni lavoratore assunto !
Siamo insomma di fronte a una cifra che, in presenza di un mercato finanziario e assicurativo privo di imperfezioni, potrebbe essere agevolmente sostenuta da qualsiasi impresa, piccola o grande che sia. Quest’ultima potrebbe infatti assicurarsi contro il rischio di una sentenza sfavorevole, semplicemente pagando un piccolo premio per ogni lavoratore impiegato.[24]
Si potrebbe a questo punto obiettare che il mercato finanziario e assicurativo non è affatto perfetto, e che attualmente non sussistono le condizioni per garantire alle piccole imprese la stipula di contratti assicurativi di questo tipo. Ma di fronte a una simile obiezione si può ribattere solo in un modo: non saranno certo i lavoratori a pagare il costo dell’inefficienza e dei regimi non concorrenziali in cui versano i mercati finanziari e assicurativi italiani !
5. L’articolo 18 incentiva il sommerso e il lavoro nero
L’affermazione può essere smentita in molti modi. Innanzitutto, le ricerche chiariscono che proprio negli anni in cui si sono registrate le riforme più significative in direzione della flessibilità del lavoro, si è rilevata la crescita più significativa del sommerso in percentuale del Pil. Si osservi a questo proposito la seguente tabella. Nella prima colonna è riportata la variazione, tra la fine degli anni ’80 e la fine degli anni ’90, dell’indice di protezione dei lavoratori: una variazione negativa indica che le protezioni si sono ridotte e che la flessibilità del lavoro è aumentata. Nella seconda colonna è invece riportata la variazione della quota di sommerso in rapporto al Pil.[25]
|
Paese |
Variazione |
Variazione |
|
Italia |
-0,8 |
+5,1% |
|
Spagna |
-0,6 |
+3,2% |
|
Svezia |
-1,3 |
+2,1% |
|
Norvegia |
-0,4 |
+2,7% |
|
Danimarca |
-0,9 |
+7,9% |
|
Germania |
-0,7 |
+4,2% |
|
Francia |
+0,3 |
+6,5% |
|
Regno Unito |
0 |
+3,7% |
|
Austria |
0 |
+1,7% |
|
Stati Uniti |
0 |
+2,4% |
Naturalmente, sarebbe errato trarre da questi dati una qualsiasi relazione causale. E’ evidente cioè che la correlazione tra i due fenomeni è spuria, ossia con ogni probabilità a sua volta dipendente da un terzo fattore non considerato. Meriterebbe di essere indagata, a tal proposito, l’esistenza di eventuali correlazioni tra queste variabili e un indice del potere contrattuale dei lavoratori. Non si può escludere, infatti, che la riduzione di quest’ultimo possa spiegare buona parte sia della riduzione delle protezioni che dell’aumento del sommerso nel corso degli anni ’90.
Ad ogni modo, ciò che risulta piuttosto evidente è la totale assenza di elementi in grado di sostenere l’idea che le protezioni generino sommerso e che quest’ultimo verrebbe riassorbito solo se si eliminassero le prime. A ulteriore sostegno di questa evidenza è possibile riportare anche il seguente dato nazionale. La percentuale di lavoro irregolare sul totale degli occupati nell’industria ammonta nel Mezzogiorno d’Italia al 41,8%, mentre il Centro-Nord si attesta su un modesto 12,1%.[26] Considerato che le norme di protezione dei lavoratori si applicano uniformemente sull’intero territorio nazionale, si deve ritenere che queste siano in grado di spiegare ben poco del divario esistente tra le due aree del paese.
6. L’articolo 18 genera inefficienza e impedisce l’innovazione tecnologica
Anche questa obiezione appare smentita dai fatti. La realtà è che un elevato grado di protezione dei lavoratori non risulta affatto associato a una bassa crescita della produttività e dell’innovazione. Se si pongono a confronto l’indice di protezione dei lavoratori da un lato e la crescita media della produttività del lavoro dall’altro, si rileva la sostanziale assenza di correlazioni tra le due variabili o al limite una correlazione moderatamente positiva, non certo negativa:
|
Fig. 2 – A un’alta protezione dei lavoratori non corrisponde una diminuzione della produttività |
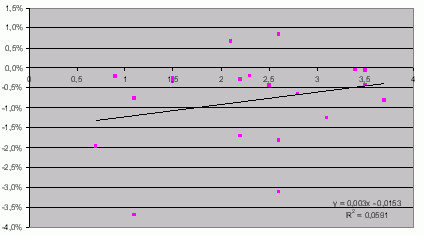 |
|
Ascisse (X): Indice di protezione dei lavoratori (EPL) |
Questa evidenza risulta sostanzialmente confermata per il caso della spesa in ricerca e sviluppo. In un recente studio dell’OCSE, infatti, si ammette che gli effetti del livello di protezione dei lavoratori sulla ricerca e lo sviluppo risultano “complessi e ambigui”.[27] Da un lato, infatti, le innovazioni impongono licenziamenti e nuove assunzioni, che risultano ovviamente agevolate nel caso di bassi indici di protezione. Dall’altro, però, gli elevati livelli di protezione possono indurre le imprese ad assicurare ai propri dipendenti un continuo training innovativo, il che tende a favorire l’attività di ricerca interna all’azienda.
Sussistono del resto ottime ragioni per ritenere che un elevato grado di protezione dei lavoratori induca le imprese ad essere più efficienti ed innovative. In primo luogo, lavoratori più sicuri sono più propensi a investire in capitale umano specifico, ossia risultano più disposti ad uniformare il proprio percorso di formazione alle esigenze dell’azienda presso cui lavorano. In secondo luogo, in presenza di alti livelli di protezione per i lavoratori, le imprese cercheranno di massimizzare la produttività degli stessi, attraverso la crescita del capitale e la continua innovazione di processo.
Basti notare, a questo proposito, come la Svezia, la Germania, il Giappone, la Francia, la Corea e molti altri paesi caratterizzati regimi di protezione del lavoro piuttosto elevati, sono anche quelli in cui la spesa privata per la ricerca risulta tra le più alte del mondo.
In un certo senso, è come se in questi paesi, invece di accrescere la libertà delle imprese attraverso la rimozione delle tutele dei lavoratori, si sia deciso di vincolare l’azione delle prime attraverso l’estensione delle difese di questi ultimi. Un vincolo decisamente fruttuoso, dal momento che ha indotto le imprese a generare una maggiore spinta verso l’innovazione e la ricerca.
Conclusioni
In questi giorni il governo socialdemocratico tedesco si appresta ad introdurre una riforma del mercato del lavoro finalizzata ad accrescerne significativamente la flessibilità, e in particolare a rendere più agevoli i licenziamenti. La giustificazione avanzata a sostegno di questa iniziativa è che occorre ridimensionare i regimi di protezione dei lavoratori per far sì che l’economia tedesca riprenda a crescere e a creare occupazione.
In tutta Europa, insomma, si continua a cercare di risollevare il malato con la ricetta sbagliata. Al fine di assecondare un mondo imprenditoriale infiacchito e una comunità finanziaria sempre più potente e privilegiata, ci si ostina a proporre riforme nella sola direzione della compressione della spesa pubblica e della flessibilità del mercato del lavoro. Si evita invece accuratamente di affrontare il nodo cruciale della crisi di questi anni, quello relativo al palinsesto macroeconomico e al regime di restrizione monetaria e fiscale imposto dal Trattato dell’Unione e dal Patto di stabilità.[28] Per uscire da questo vincolo cieco e per spostare finalmente il fuoco del dibattito sui temi cruciali della riforma del palinsesto macroeconomico europeo, delle politiche di lotta ai monopoli e alle rendite, della programmazione industriale e delle dotazioni infrastrutturali, è necessario lanciare un segnale politico, quello secondo cui il tempo dello smantellamento delle tutele dei lavoratori è finito. Il referendum rappresenta un’occasione importante, in questo senso. La migliore occasione, dopo anni di incontrastato dominio dell’ideologia e della pratica liberista.